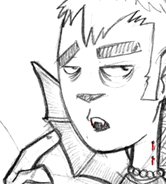
Cos'è Sketch-O-Graphy?...bella domanda...vedetela come volete...c'è chi prende prozac...chi picchia vecchiette...io disegno! eh si... è come una mia personale terapia.
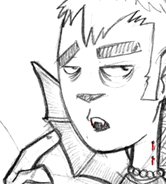
On October 11, 2001, American flags burned in the streets of Rome out of hate, as they did in other European capitals. It was business as usual for the extreme left, after the short-lived rhetorical break in the days immediately following September 11. But on the same day, thousands of Old Glories, along with the Italian and Israeli flags, were instead flying proudly, this time out of love and solidarity, in the central, neo-classical Roman Piazza del Popolo. My daily newspaper, Il Foglio, had called for this show of support, and it was a rousing success with the full support of the Center-Right coalition that had just come to power.